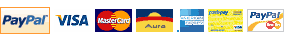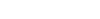È raro trovare, specie nel panorama letterario contemporaneo, una dimostrazione così centrata e consapevole di poesia pensante, come quella che intride le pagine de La saggezza degli ubriachi (La Vita Felice Edizioni, 2017, pp. 92, Euro 13), di Stefano Vitale. L’autore torinese trascende i dati della cronaca – dalle cui occasioni, peraltro, gli capita di muovere – mentre guarda all’uomo sub specie aeternitatis, cioè alla universalità spaziotemporale della humana conditio: e questo gli consente, per istinto e per assunto, di postulare ancora la validità e la dicibilità del “noi” con cui sfonda la soggettività auto-centrica dell’io, dal momento che «siamo figli di un destino comune». La potentissima tessitura esistenziale che permea le composizioni di questo libro realizza e traduce l’“incessante e necessitante indagine” di cui parla Alfredo Rienzi in Prefazione: sull’essere, cioè sul tempo, gli altri, l’immagine di noi, i limiti, i confini, i condizionamenti, la necessità di fingere di «essere normali» per farsi accettare e meglio tutelare gli abissi della propria identità; ma anche su come la ragione percepisce e organizza la cosiddetta “realtà,” imponendole un dominio «patetico» giacché invece «dentro e fuori tutto è buio / buio pesto», e tra noi e il mondo rimane una «chiusura stagna».
È una poesia che esplora i sentieri del Dasein heideggeriano mettendo in opera una martellante e insistita ricerca di senso, aprendosi cioè senza ripari alla consapevolezza, autentica quanto più feroce e rigorosa. La ricerca di senso ci è connaturale nella misura in cui siamo animali supercoscienti, e per ciò stesso braccati dall’incomprensibile. Interrogando l’essere interroghiamo noi stessi, e viceversa. Vitale accoglie i limiti negativi della finitezza come “deiezione” dell’essere “gettati” nel mondo («noi qui, / cose tra le cose / posate per caso sulla tavola del tempo») in un «esilio obbligato» che diventa «regno dell’attesa» dove appunto si attraversano anni ed anni ad aspettare, spesso inutilmente, un «segnale dal futuro». Esistiamo nella cecità opaca dello stare a fronte, dentro i limiti di un corpo che, a differenza degli altri, non riusciamo a vedere da fuori: “Io sono e non mi vedo” è la cifra emblematica della nostra realtà percepita, sempre parziale e ingannevole. Trascorriamo la vita sostanzialmente estranei al nostro mistero, senza sapere come e perché «questo sangue scuro / (…) intanto macina nelle nostre vene / e agita le nostre sere». Il «notturno continente che tutti ci racchiude» non è soltanto la notte che succede a ogni tramonto, ma lo sconfinato e irrisolvibile enigma nel quale ci ritroviamo immersi. Il Vuoto domina sovrano, è ciò da cui veniamo e in cui finiamo per tornare: come scrive Adam Zagajewski, citato da Vitale in uno dei colophon interni, “vi sono / più oceani che terraferma. Più ombra / che forma”. Sintetizzando il sugo di migliaia di esperienze, la scrittura porta alla luce alcune pregnanti definizioni del vivere che è merito dell’autore porgere senza la presunzione apodittica delle “sentenze”, ma con la sobria naturalezza delle constatazioni. Così accade, per esempio, allorché Vitale, “correggendo” Shakespeare quattro secoli dopo, nota che «siamo fatti della stessa materia dei nostri sbagli». La finestra di tempo da cui siamo racchiusi ci rende intrappolati «nell’astuzia della Storia» che massacra le generazioni; tanto più oggi, ridotti come siamo a «schiavi / di una Storia / di cui si sono perse / ormai le chiavi».
Il poeta è molto abile nel far sentire il tritume della quotidianità inautentica: scrive di «grigio presente dei minuti pesanti», di «tempo andato a male», di «noia», di «pastoia», di «deserto d’ombre d’inutili ore». Ma vivere significa andare oltre, «oltre il dolore / oltre una porta chiusa per sempre», poiché appunto c’è una «luce instancabile che spinge / oltre le umiliazioni». Il gesto di oltre-passare implica una presa in carico della negatività da cui si vorrebbe risorgere, che viceversa ingigantisce quanto più rimossa. Traguardare lo spiraglio di una possibile liberazione significa dunque muoversi «verso il fondo» esercitando l’attitudine di «archeologi di noi stessi» in cerca dei «fossili della speranza». Occorre trovare, però, l’anello che non tiene: infilarsi nel varco, deragliare, usare il «pensiero sbilenco» nella «torsione dell’attimo sgrammaticato». Ecco la “saggezza degli ubriachi” che, nell’ebbrezza alcolica, escono dai vincoli normativi per restituirsi al mondo immediato degli istinti, alla presenza pura dell’esistente, alla natura originaria delle cose.
La poesia di Stefano Vitale certifica lo scacco definitivo della ragione raziocinante, quella stessa che – annodando i nostri pensieri e portandoli al sistematico fallimento – dimostra di per sé come «la forza del ragionamento / è poca cosa». La Verità di conseguenza, se vogliamo ancora scriverla con l’iniziale maiuscola, è solo «presunta», così come la «precisione» è soltanto illusoria. Inseguiamo la perfezione abbarbicati alla cima dell’imperfezione, da cui «tutto ci sfugge». Gli specchi non sono «cristallini» ma «inevitabilmente» deformati. Le diverse realtà in gioco all’interno di ogni porzione di mondo sono prismi caleidoscopici con milioni di facce in mutamento, come le nuvole, «miraggio d’immagini, specchio della nostra mente». È possibile perciò avanzare non più che congetture, cosa che ci rende «eterni dilettanti della vita», controfigure di noi stessi, «fragili figure di sabbia / sul confine della memoria». Quest’ultima esercita un peso che può contrastare l’itinerarium mentis ad veritatem e certamente la sua innocenza salvifica, tanto che «un vuoto di memoria / talvolta, salva la vita». Anche la parola costituisce, per certi versi, un intralcio alla verità; ma d’altra parte è uno strumento simbolico privilegiato e insostituibile per tentare di avvicinarla. La parola cerca di colmare il divario tra la cosa e la conoscenza, ma della cosa rappresentata non riesce a cogliere l’essenza. Ci si avvicina di più, invece, nel «silenzio / dei nostri pensieri nascosti e veri», quelli che parlano in noi una lingua straniera ma insieme arcanamente familiare: «Un vortice di pensieri / senza padrone / cadenza straniera / memoria d’altra storia?»
Come si arriva, dunque, al cuore misterioso della vita? Andando «oltre il confine del cortile» e il «crocevia del tempo», poiché «il Vero sta nell’oltrepassare, / nel dettaglio dove si nasconde al primo sguardo / il nostro Esserci». Come in una sorta di epoché fenomenologica, occorre anticipare l’agguato delle abitudini, la conferma dei meccanismi percettivi, l’edificio di strutture razionali che ci scherma dalla purezza dell’essere.
Ridurre il campo visivo
alla coda dell’occhio
per meglio vedere ciò che resta nascosto
allo sguardo troppo sicuro.
Il che significa anche abdicare all’oltracotanza dell’uomo saccente e accentratore, che conquista/devasta il mondo. Occorre affidarsi a un altro tipo di ragione, ontologica e paritaria, modulata cioè dal punto di vista delle cose. La via per evitare le «trappole» del razionalismo? Silenzio e «mente immobile»:
Contro l’ingarbugliarsi delle cose
vince la mente immobile.
E quindi, «diventare muro, insetto, foglia» placando l’ansia di combattere e contrapporsi per imporre un “dominio” che la distesa dei secoli e il silenzio nero del cosmo rendono risibile, oltre che esiziale. Ecco la «lezione dei fiori»:
La lezione dei fiori
è nel loro essere fiori, e questo basta,
mondo che rinasce
nella pura insolvenza del vivere.
Davanti ai nostri occhi si spalanca l’oceano della Vita, che ammiriamo ma «non possiamo afferrare». La natura è «incomprensibile e chiarissima» al contempo, e per intenderla «non servono i libri che abbiamo letto / perché non sempre comprendono / la lingua delle cose». Oscilliamo costantemente tra le «ombre / di un delirio di purezza» e il «lucido buio», cioè tra il mistero che si vela e che si svela. Le cose ci guardano dall’eternità, con “occhio calmo e molto chiaro” come i ciottoli di Herbert, che non si lasciano “addomesticare”. Vitale cerca dunque di stanare le cose dalla loro autonomia, dal loro sonno immemoriale, dal loro segreto intangibile. Cerca di conseguenza una parola nuova, diversa, piena, in grado di coincidere con la cosa denotata.
Tirar fuori dalla selva del tempo
una parola certa e precisa
che ci rassomigli una volta per tutte
per dare un senso
al silenzioso scrutarsi delle cose.
Coglie le “scene” fenomeniche del mondo ma tende in realtà a ciò che precede la ragione delle parole convenzionali, la «necessità» e l’«automatismo creaturale», cioè il rapporto geniale che regge le cose dall’interno e le tiene fra loro unite, dentro l’intelligenza dei fatti e degli eventi. Raccoglie via via, così, «i sogni delle piante», il «sordo salmo del silenzio», «l’alfabeto muto / dei tetti», la sera che «mi parla di sé / e non capisco», l’aria che «respira se stessa», ecc.
La poesia si slarga ad accogliere il colore stesso del vuoto e la forma sconfinata del silenzio («parole invisibili / su una lavagna trasparente»), masticando le «perfette costellazioni di niente / nella nera calma che inonda il mondo». Ci si può arrivare, forse, anche affondando nel «grembo della lingua» per cercarne le balenanti rivelazioni («gli istanti illuminati») che splendono dalla “miniera della mente” come «oro inatteso». Ma il traliccio estetico da cui è sorretto il movimento della scrittura resta comunque quello che porta dal contingente all’universale, dalla storia alla natura, dal fisico al metafisico, dal rumore al silenzio, dalla sostanza all’essenza. È ancora possibile il “canto”, questa «piccola ostinata intima luce / che riposa nel tabernacolo / delle nostre viscere»? Sì, sembra rispondere Vitale con tutto il libro, malgrado l’inafferrabilità della forma, la complessità estrema del mondo, la terra ormai desolata e il «sopravvenuto disincanto»:
e niente più rassomiglia
in questo dilagare di riflessi
se non quest’assenza
di noi a noi stessi
perduti nello specchio infranto del suono
del sopravvenuto disincanto.
Marco Onofrio