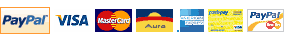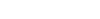.
Il tema è quello dell’incomunicabilità fra un padre e un figlio, del loro amore impossibile, della loro distanza incolmabile. Vari potrebbero essere i riferimenti, per approssimazione, a esperienze poetiche analoghe, dal padre prematuramente scomparso, percepito come assenza traumatica, di Pascoli, a quello di Sbarbaro in “Pianissimo”, dichiarazione di attaccamento incontaminato, alla figura paterna che diventa città di odori e ombre di Giorgio Caproni, al “Padre mio” di Alda Merini, che diventa ansia metafisica e confine celeste, e così via. Eppure se dovessi riscoprire un’esperienza di formazione con cui “Notizie da Patmos” possa confrontarsi, io penserei immediatamente alla “Brief an den Vater”(1919) di Franz Kafka “Und wenn ich hier versuche, Dir schriftlich zu antworten, so wird es doch nur sehr unvollständig sein, weil auch im Schreiben die Furcht und ihre Folgen mich Dir gegenüber behindern und weil die Größe des Stoffs über mein Gedächtnis und meinen Verstand weit hinausgeht.”.
“E se anche provo a risponderti scrivendoti, il mio tentativo sarà per forza incompleto, sia perché anche nello scrivere mi sono d’ostacolo la paura che ho di te e le sue conseguenze, sia perché la vastità della materia trascende la mia memoria e il mio intelletto.” (trad.mia).
Kafka dichiara come figlio l’impossibilità di riportare l’esperienza del vissuto, perché la confidenza si slabbra nel timore e perché l’assiduità diventa atemporale, l’episodico si tramuta nell’innumerabile: la memoria e l’intelletto cedono di fronte all’impresa della ricostruzione del rapporto. Ci si trova invischiati nei territori dell’indicibile. Il ‘topos’ identificabile è quello del viaggio mistico, in cui conta l’esperienza, ma conta soprattutto fare i conti con le parole che possono o non possono riferirla. E questo riguarda il rapporto familiare più stretto che possa esistere. Non occorre dunque stupirsi se “Notizie da Patmos” è introdotto dai versi del X canto dell’Inferno, il discorso profetico di Farinata a Dante sul suo futuro esilio in terra. La prefigurazione del distacco non può però che proiettarsi, per un credente come Dante, nella dimensione dell’eternità: la separazione insostenibile sarebbe per Dante proprio quella dal Padre Divino. Fabrizio Bregoli non ci pone dunque come orizzonte la camera da letto, le stanze in cui risuonavano i passi paterni, le passeggiate nei parchi e nelle vie, ma Patmos, l’isola dell’ascensione a Dio e della terribile rivelazione. Il punto di partenza è un territorio sacro, da cui ci si alza nel tentativo di una ricongiunzione. Rocce, sterpi, cielo numinoso: non aria domestica. La possibilità dell’annullamento delle distanze fallisce perché il padre, se tu lo ritrovassi, ti terrebbe lontano anche abbracciandoti e se ti parlasse non riusciresti a capire e a riportare le sue parole. Incommensurabilità e ineffabilità: dall’Inferno si è già arrivati nell’ultimo regno, il Paradiso, con la categorizzazione di quanto di più sublime e atroce possa però riservare quel luogo: è l’avvicinamento ma senza poter arrivare al ricongiungimento, è l’intendere per poi trovarsi sgomenti a corto di parole. Se la mistica non può dunque che definire per approssimazione, Bregoli prova ad affidare il suo tentativo sperimentale di afferrare l’impossibile alle scienze esatte. La prima sezione, che dà il titolo all’opera, è aperta da una riflessione personale sull’algebra, rappresentata come “Uno spazio dominabile. Finalmente nostro. Una paternità restituita”, e subito dopo nominata “Arte della riparazione./(Come la poesia)” (p11). Fabrizio Bregoli affida l’opera della ricongiunzione all’algebra e alle sue correzioni e il fatto che il ricucire umano venga affidato non a un afflato sentimentale, ma a una scienza esatta, da una parte si riflette sulla ricerca di una precisione formale nella cura del lessico e nell’incatenarsi dei versi: si sceglie ad esempio l’endecasillabo, che è il verso amoroso per antonomasia della nostra letteratura, ma piegato a uno scandirsi metallico, a una fredda forgiatura. L’affidamento all’algebra indica paradossalmente una prospettiva utopica che mi commuove: per ritrovare il padre e il suo affetto, ci vuole qualcosa di perfetto, in modo che l’equazione una volta risolta non sfugga più dagli occhi e dalle mani e che l’amore non si pieghi alla mutevolezza, ma rimanga per sempre risolto. Un noi minimo, ma non più divisibile, un binomio inscindibile.
Che il bene perduto, il termine su cui si esercita questa ricerca algebrica di congiunzione sia la figura del padre, non può che portare al delineamento di una mancanza e di una successiva incomunicabilità ontologica. È come se l’atto della generazione e della fondazione dividesse ‘ipso facto’ piuttosto che unire. Le due identità si stagliano l’una di fronte all’altra come due caseggiati, ricchi di vita, di interessi, di passioni e collezioni al proprio interno, ma che, trattenuti dalle proprie fondamenta di cemento, mai potranno attraversare la sottile linea d’aria che li divide. Si occhieggia, da una parte all’altra, si intuisce, si deduce. L’atto della generazione diventa atto univoco di creazione e il padre naturale di ciascuno assume le caratteristiche del Padre biblico dell’antico Testamento. Inavvicinabile, pure se si è sicuri della sua presenza.
Se l’intenzione iniziale si pone nel solco di una prospettiva scientifica tradizionale e rassicurante, gli esiti successivi non possono che spostarsi verso i confini della relatività: la poesia di Bregoli diventa quantistica e l’oggetto dell’osservazione sfugge sempre alla cattura definitiva, perché si sposta insieme al punto di vista dell’osservatore. Basta uno scarto minimo. Da punto a onda. Un poeta non può fissare alla pagina l’argomento della poesia nella sua definizione esaustiva, perché mentre scrive cambia prospettiva ed evolve il proprio sentire. Si fanno tentativi per approssimazione, accettando certi accosti formali come se fossero gli esperimenti del piccolo chimico: si cerca disperatamente di trovare una rima con ‘padre’ e poi con il nome del genitore. È una poesia che si consegna immancabilmente al fallimento, è rapporto con l’inconoscibile dell’altro, mai esauribile, madornale nel caso che l’altro sia proprio chi ci ha concepito e generato. È la ricerca di un ‘noi’, non perduto, ma probabilmente mai esistito.
Scrivo di noi, di un verbo contraffatto,
del suo frutto disseccato
sul pegno delle labbra. Scrivo di noi
grammatica di un vento lapidato.
(Vocabolario minimo, vv.9-12, p.19)
mario monicelli- padri e figli

.
Le distanze fra scienza e slancio di fede si accorciano e si allungano, in un mirabile progetto di composizione che ha ancora come punto di partenza la struttura tomistica della Divina Commedia, seppure disgregata tra le parentesi della “digressione quantistica”. Ma in questo swing estremo fra i campi, le discipline, gli stili, in questo febbrile ricucire senza che il filo abbia potuto trovare la cruna dell’ago, si può, dopo la scienza, ritornare alla preghiera: “Tutto comincia così, con una preghiera. Nel nome del padre, solo nel suo nome. Quel verbo ossuto, la sua parola murata. Latino mansueto dello schianto.” (Nel nome del padre, p.18). E la preghiera iniziata nel nome del padre potrebbe terminare con i versi di Andrea Zanzotto scritti per la morte del genitore: “E così sia: ma io/ credo con altrettanta/forza in tutto il mio nulla, /perciò non ti ho perduto/o più ti perdo e più ti perdi, /più mi sei simile/più m’avvicini.” (Così siamo, vv.17-22, da IX Ecloghe, 1962). Anche la tensione lirica di Zanzotto rivela un suo linguaggio, mistico o quantistico, che lo accomuna, da padre poetico, a Bregoli, di fronte alla impossibile cattura dell’essenza del padre naturale: “non sei né soggetto né oggetto/né lingua usuale né gergo/né quiete né movimento/neppure il né che negava” (ibid., vv.10-13). E tale radicalità riecheggia nei versi di Bregoli: “Di noi rimane/ Ciò che non è stato.” (Quarto comandamento, vv.14-15, p.24). “(…) Così di simile/ in simile l’uno nell’altro scissi/ a compierci in un tutto disgregato.” (Omeomerie, vv.4-6. p. 29). “Onora il nulla/il solo che ci è dato.” (Quarto comandamento (ripresa), vv.5-6, p.32)
La preghiera misura i passi che segnano la distanza incolmabile tra il figlio e il padre, il bisogno che un amore finalmente divampante, possa bruciarla. Pier Paolo Pasolini riscrive la prima preghiera di ogni cristiano, che ridiscende ad un piano domestico, infantile con quel suo padre, ufficiale dell’esercito, lontano, diverso, grandissimo:
Ti confido il mio dolore;
e sto qui ad aspettare la tua risposta
come un miserabile e buon gatto aspetta
gli avanzi, sotto il tavolo: Ti guardo, Ti guardo fisso,
come un bambino imbambolato e senza dignità.
(Padre nostro, vv.44-48, da “Affabulazione”, 1969)
Teologia e famiglia si confondono. Dio è sempre assente, come il padre. In questo senso l’impossibilità di ipostatizzare, si rivela come caccia a un oggetto che sempre si sottrae e che alla fine da preda diventa paradossalmente tiratore, come nel Caproni de “Il Franco Cacciatore”(1982) o de “Il conte di Kevenhüller”(1986). E Bregoli si appella proprio a questo padre cacciatore, che si fabbrica addirittura da sé i proiettili assassini: “tu amavi fabbricarti le cartucce/ con antica perizia di speziale” (“Comuni divergenze”, vv.4-5,p.63). Di Caproni è la cosiddetta ‘res amissa’, la cosa perduta. Non si può provare sgomento più grande quando la cosa è quotidianamente accanto a te, ma inattingibile, oscura, lontana nell’incomunicabilità dei pensieri, quando la somiglianza della carne potrebbe invece parlare di comunione e forse di abbracci. Con i padri, alla fine, la si dà per persa, anche se resta inconfessabile una residua speranza.
Bruciamo la nostra distanza.
Bruciamola, mio nome.
Cessiamo di viverla come
Il sasso la sua ignoranza.
(G. Caproni, Due madrigaletti, 1986)
Forse l’unico modo di entrare veramente a contatto col padre prevede l’indebolimento di uno dei due soggetti. È il corpo di Anchise che si avvinghia a Enea per essere salvato da Troia in fiamme. “Ergo age, care pater, cervici imponere nostrae:/ Ipse subibo umeris nec me labor iste gravabit” libro II 707-708. “Presto padre mio dunque, sali sulle mie spalle, io voglio portarti né questa sarà fatica per me”. (trad. di Rosa Calzecchi Onesti). È solo nell’emergenza che ci si ritrova e ci si riconosce. E Bregoli scrive: “Fu dunque nella fuga il nostro accoglierci?” (Fughe, v.1, p.61).
.
silvano alloggio – padri e figli

.
Rimanendo nel campo dell’epica ogni padre è perduto dopo averci generato e la sua assenza simbolica, diventa a un certo punto reale e ci riempie l’anima di dolore e nostalgia: Telemaco va alla ricerca tra gli scampati di Troia di notizie di Odisseo che non ha mai conosciuto. E per ogni figlio è questa la strada compiere, anche se il padre abita nella tua stessa casa: egli è il fantasma, l’Ulisse lontano e indifferente. Ma l’impossibilità di accedere all’essenza del padre può infine diventare la vocazione stessa dello scrittore a cui si sottrae la pagina e ogni tentativo si scontra con l’imboscamento della parola, con il suo scivolamento inafferrabile. Io sono stato poeta per l’assenza del padre, perché non ho dovuto obbedire alle parole del Padre che pretendevano il sacrificio, perché ho cercato il suo mistero nel mistero della poesia o perché ho sostituito la vittima neppure con l’agnello, ma esplodendo in maniera premeditata un colpo a salve:
Io invece preferisco la poesia,
la scienza bellicosa del disarmo.
Quel suo sparare a salve
per non fallire un colpo.
(Comuni divergenze, vv.14-17, p.63)
Oppure la maledizione è stata gettata e non c’è possibilità di remissione, di cambiamento di rotta. Il padre e la poesia non comunicano con il figlio. La poesia e il padre sono la stessa cosa.
In fondo non è proprio quest’ottuso
dialogo col silenzio, la poesia?
(Somiglianze, vv.10-11 p. 62)
Rimane la poesia, spietata e imbelle
tutt’intero il suo soldo bucato,
l’ovvio scrivere ciò che non sai dire
– assioma sghembo d’un figlio scontato.
Onora il nulla
il solo che ci è dato.
(Quarto comandamento, ripresa, vv.1-6)
Per tirare infine le somme, quello che più mi appassiona in questo procedere è l’attentissima riflessione sulla possibilità attuale del linguaggio poetico e come questo trovi la sua sostanza e il suo spessore nella materia che sta trattando: ne sia, per utilizzare un termine dantesco, cattolico, teologico, consustanziale. Inscindibile è infatti la connessione tra l’esperienza esistenziale e la riflessione linguistica, l’incompletezza originaria e l’assurdo dell’essere umani, insieme al tentativo tremendo di tenerne insieme le parole, di arrampicarsi sulle rocce vertiginose di Patmos e sulle pagine taglienti del libro, senza cadere nell’abisso del silenzio annichilente.
Perché c’è sempre un verso
sghembo che non tiene, la rima
che fa acqua a dire tutta
intera la ferita, noi nell’opera
di un mondo già combusto
ciò che resta. L’ingiusto della vita.
(Rimari, vv.11-16, p.39)
La poesia è il padre, il padre è la poesia Si cercano i modi propri per esprimere questa identità e non sono versi compiuti e gloriosi, ma lallazione, dislessia, inanità, confessione dell’inesprimibile. Si arriva sino al paradosso e non è un colpo di scena, ma quello che si percepiva sin dall’inizio: si scrive di ciò che non si può scrivere, si raccolgono cenci, materiali di compostaggio, frammenti, cimeli e si prova a lasciare comunque una testimonianza di partecipazione:
Di questo scrivo
Di ciò che non si compie. Del coraggio
Che non si fece verso, vi si perse
Per difetto di vita, debito di cielo.
(Offertorio delle ceneri, vv.9-12, p.66)
Come afferma in maniera assolutamente convincente Piero Marelli nell’introduzione, la sfida all’esaurimento storico del linguaggio e dei temi della poesia è qui raccolta evidenziando innanzitutto la precarietà originaria dell’operazione, ma testimoniando su queste basi di riconoscenza alla debolezza, una testarda assunzione di responsabilità nei confronti della realtà contemporanea. Il lenzuolo steso della retorica diventa qui il foglietto con le parole dell’unica notizia che da sempre ci aspettiamo. Nella centrifuga delle parole tutto si asciuga e si concentra: rimane una mano che scrive e un volto che occorre riconoscere, familiare e per sempre sfuggente. Solo questo vale e solo questo basta. Poesia, padre lontano.
Paolo Gera