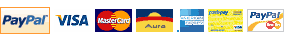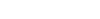Su L'altrove - Appunti di Poesia recensione per «Nebbia» di Antonio Mazzanti

Nebbia
|
|
| autori: | Antonio Mazzanti |
| formato: | Libro |
| prezzo: | |
| vai alla scheda » | |
L’esordio poetico costituisce sempre un atto di posizionamento all’interno del campo letterario, una dichiarazione di appartenenza e insieme di distacco dalle genealogie che lo precedono. Nebbia di Antonio Mazzanti (La Vita Felice, 2025) si presenta come un’operazione di recupero della dimensione civile della poesia, un gesto che assume particolare rilievo nel panorama contemporaneo caratterizzato da una persistente tendenza all’interiorizzazione lirica o, all’opposto, alla sperimentazione formale fine a se stessa. La raccolta si sottrae a entrambe le derive attraverso una strategia compositiva che fonde consapevolezza metapoetica e urgenza testimoniale, costruendo un discorso che oscilla tra riflessione sulla scrittura e rappresentazione di esistenze marginali.
La prefazione di Giorgio Ghiotti individua con acume le coordinate essenziali del progetto mazzantiano, richiamando l’eredità della Spoon River Anthology di Edgar Lee Masters e delle News of the World di Philip Levine. Il riferimento alla tradizione americana risulta particolarmente pertinente: come in Masters, anche in Mazzanti emerge la volontà di dare voce a una comunità di esistenze comuni, sospese tra l’anonimato e la necessità di essere nominate. Tuttavia, mentre Masters costruisce una coralità compatta attraverso la forma dell’epitaffio, Mazzanti articola una polifonia più frammentata, dove le voci individuali non si compongono in un affresco unitario ma restano sospese nella loro singolarità irriducibile.
La struttura architettonica della raccolta rivela una precisa consapevolezza compositiva. La sezione inaugurale, “Inchiostro e memoria”, funziona come dichiarazione di poetica, esplicitando il nodo problematico tra scrittura e rappresentazione che attraversa l’intera opera. Inchiostro versato introduce immediatamente la metafora bellica della scrittura come tradimento e perdita:
Scrittura,
sei un tradimento che seduce e consuma.
Un campo disseminato di mine inesplose,
dove ogni parola è un passo incerto.
Io, generale senza esercito,
ti comando sapendo di perdere.
L’immagine della scrittura come campo minato, della parola come «passo incerto», rivela una concezione drammatica dell’atto poetico, lontana da ogni illusione di trasparenza comunicativa. La figura del «generale senza esercito» condensa l’aporia del poeta contemporaneo: investito di un ruolo che gli conferisce autorità ma privato degli strumenti per esercitarla. Il registro si fa più violento con l’apostrofe «Scrittura puttana», che richiama il legame di dipendenza e sfruttamento reciproco tra poeta e linguaggio. La brutalità dell’immagine («ti offri a tutti ma torni da me / a succhiare parole / da un corpo che non smette di sanguinare») esprime la dimensione vampiresca della scrittura, che si nutre dell’esistenza stessa del poeta in un circuito di consumazione reciproca.
La riflessione metapoetica prosegue in Necrologio, dove l’atto stesso della scrittura assume connotazioni thanatiche:
Scrivevo mondi che crollavano,
li chiudevo nei cassetti,
credendo fossero semi.
Ma la terra era sterile,
e le parole,
sterili anch’esse.
Ogni pagina un’autopsia.
L’immagine dell’autopsia è particolarmente efficace: la scrittura come dissezione di corpi morti, come esame post-mortem di esistenze già concluse. La progressione verso l’autodistruzione («ho spezzato la penna / e inciso l’ultima frase sulla mia pelle») conduce a una circolarità paradossale: solo quando la scrittura coincide con il corpo stesso del poeta, solo quando diventa «inchiostro scarlatto», essa ottiene finalmente riconoscimento. La chiusa («E così, finalmente, / lessero qualcosa di mio: / il mio necrologio») esprime con amara lucidità il destino del poeta: essere letto solo nella propria assenza.
Un segno radicalizza questa riflessione sulla riduzione dell’esistenza a traccia minima:
Tutto si riduce a questo:
un nome, un cognome,
due date incise nel freddo.
In mezzo un trattino.
Un segno minimo, timido,
che custodisce
le parole che hanno retto ponti
e quelle che li hanno fatti crollare.
Il trattino diventa emblema dell’intera esistenza, quel «segno minimo, timido» che separa nascita e morte, che contiene «le parole che hanno retto ponti / e quelle che li hanno fatti crollare». La condensazione estrema dell’esistenza in un segno grafico richiama la riflessione di Magrelli citata da Ghiotti, ma in Mazzanti assume una dimensione più pessimistica: non si tratta della forma come «chiave pronta a spalancare mondi», ma della forma come riduzione, come compressione dell’esistenza in un dato epigrafico che «nessuno leggerà davvero».
La sezione dedicata all’infanzia e all’adolescenza (Ultimo banco, Bambino, Bambina, SerD) introduce un registro diverso, meno metallicamente consapevole e più emotivamente coinvolto. Questi testi affrontano la fragilità dell’infanzia e la sua esposizione precoce al dolore senza cadere in sentimentalismi. Particolarmente riuscito è SerD, che rappresenta l’iniziazione all’età adulta attraverso l’esperienza del servizio per le dipendenze:
L’adolescenza è la macchina
di mia madre
verso il SerD.
Chi con le braccia rigate
di storie taciute,
chi con lo sguardo
che preferisce il pavimento.
La scelta di rappresentare l’adolescenza attraverso il dispositivo medico-sociale del SerD costituisce un’operazione di svelamento: dietro la retorica della crescita armoniosa emerge la realtà di corpi e psiche già segnati, per i quali «crescere è un verbo / che qui suona male». L’istituzione sanitaria diventa metafora di un’iniziazione rovesciata, dove «capire troppo presto / che il dolore / ha un lessico ufficiale» sostituisce i rituali tradizionali di passaggio.
Il nucleo centrale della raccolta è costituito dalla sezione “Casa e le sue voci”, dove Mazzanti dispiegna la sua «epopea dei piccoli eroi» attraverso una galleria di ritratti che attingono alla lezione americana ma la declinano nel contesto italiano, specificamente romano. Fruttarolo e Lustrascarpe utilizzano il romanesco in una funzione non folcloristica ma identitaria:
So’ l’omino der mercato,
quello che urla co’ ‘a voce roca:
«Signora, ‘sti pommidori so’ ‘na bellezza!»
E ‘ntanto peso sogni a chili.
Il dialetto non serve qui a costruire un effetto di realismo mimetico ma a marcare una posizione sociale e culturale precisa. L’uso dell’idioma locale in alternanza con l’italiano standard nelle diverse sezioni sottolinea la stratificazione sociale che la raccolta intende rappresentare. Tuttavia, il rischio di questa scelta è quello di una certa stilizzazione, di una costruzione per tipi che può scivolare verso la macchietta sociologica.
Operaio rappresenta forse il testo più riuscito della sezione, dove la dimensione temporale viene articolata attraverso una progressione di età che scandisce il logorio esistenziale:
Avevo vent’anni e ridevo forte,
avevo quaranta e ridevo meno,
avevo sessanta e mi chiedevo
dove fossero finiti i giorni
che avevo lasciato sulla catena di montaggio.
La struttura anaforica («Avevo») conferisce al testo un andamento litanico che esprime efficacemente la ripetitività alienante del lavoro di fabbrica. La riflessione finale («Forse non era il tempo a consumarsi. / Forse ero io») capovolge la metafora dello sfruttamento: non è il capitale che consuma la forza-lavoro, ma è il soggetto stesso che si autoconsuma nel processo produttivo, in una inversione che rivela la profondità dell’interiorizzazione del dominio.
Senzatetto introduce la tematica dell’identità negata attraverso la perdita del nome:
Mi chiamavo Antonio, un tempo.
Ora non mi chiamano affatto.
Dicono che un uomo sia il suo nome,
ma il mio è andato perso,
tra i cartoni che sanno di pioggia
e i passi che mi scavalcano
come fossi un corpo senza vita.
L’omonimia con l’autore (il senzatetto si chiama Antonio) introduce un elemento di identificazione che complica il rapporto tra voce poetica e personaggio. Non si tratta di un semplice espediente narrativo ma di una strategia che rivela la precarietà di ogni identità, la vicinanza tra chi rappresenta e chi è rappresentato. Il desiderio modesto di «una sigaretta per tirare avanti» e il tremore delle dita «non per il freddo, / ma per il ricordo di un gesto / che somiglia quasi a una carezza» rivelano una capacità di cogliere la dimensione affettiva residuale che persiste anche nella più estrema marginalità.
La sezione “Società storta” radicalizza la critica sociale attraverso testi come Occhi cuciti, Barcone, Bandiera estranea. Occhi cuciti adotta una struttura frammentata che mima il ritmo compulsivo del consumo di immagini:
Sangue nei vicoli,
ossa spezzate,
bambini sotto macerie.
Guardiamo.
Scrolliamo.
Avanziamo.
La sintassi nominale e la brevità versale esprimono l’anestesia percettiva indotta dal sovraccarico informativo. Il gesto dello scrolling diventa metafora dell’indifferenza contemporanea, della capacità di attraversare l’orrore senza esserne toccati. La chiusa («Chiudiamo gli occhi, / ma crediamo di guardare. / Folli noi / che guardiamo con gli occhi chiusi») rovescia il topos della cecità volontaria: non si tratta di non vedere ma di vedere senza guardare, di un’esposizione alle immagini che produce cecità anziché consapevolezza.
Barcone affronta il tema migratorio con una durezza che rifugge ogni retorica umanitaria:
Siamo una specie che si evolve per estinguersi,
e noi, migranti di spazi negati,
ci portiamo dietro il testamento della vostra civiltà:
una parola spezzata,
un sogno mai tradotto,
un uomo mai salvato.
L’apertura filosofica («Siamo una specie che si evolve per estinguersi») inquadra la questione migratoria in una prospettiva escatologica, dove il naufragio individuale diventa metafora di un naufragio collettivo. L’immagine del «respiro affannato» che «stringe un vestito vuoto tra le onde» condensa la tragedia in un dettaglio di straziante concretezza. Il mare come forza che «non restituisce, / ruba ed estingue» si oppone a ogni mitologia mediterranea della liquidità accogliente.
La sezione conclusiva, “La giostra della vita”, introduce una tonalità diversa, più lirica e meno programmaticamente civile. Testi come Amore, Carne, Risata tentano di recuperare una dimensione affermativa dell’esistenza. Tuttavia, questa sezione appare meno convincente delle precedenti, come se l’autore, dopo aver attraversato i territori del dolore e della marginalità, non riuscisse a trovare un linguaggio adeguato per la rappresentazione della gioia o dell’erotismo. Carne («Carne che chiama carne, / un incendio che non chiede permesso») ricorre a un lessico dell’urgenza e della vitalità che risulta meno originale rispetto alla lingua tagliente delle sezioni precedenti.
Dal punto di vista formale, Mazzanti opta per un verso libero di lunghezza variabile, con una prevalenza di misure brevi che conferiscono al dettato un andamento spezzato, sincopato. La sintassi privilegia la paratassi e la giustapposizione di immagini, evitando architetture complesse. Questa scelta formale risulta funzionale alla rappresentazione di esistenze frammentate, ma a tratti può produrre un effetto di ripetitività. L’uso dell’enjambement è frequente ma non sempre necessario, talvolta sembra rispondere più a un’esigenza di spezzare il verso che a una logica ritmica interna.
Il registro lessicale oscilla tra momenti di brutalità espressionista («Scrittura puttana», «carne marcia di nessuno») e passaggi di maggiore contenimento lirico. Questa oscillazione risponde alla doppia anima della raccolta, divisa tra urgenza testimoniale e riflessione metapoetica. Tuttavia, la ricerca di un linguaggio “forte” può a tratti scivolare verso soluzioni già viste, verso una retorica della brutalità che rischia di normalizzare ciò che vorrebbe denunciare.
Nebbia si inserisce in un filone della poesia italiana contemporanea che cerca di recuperare la dimensione civile senza ricadere nell’oratoria del Novecento. In questo senso, il dialogo con la tradizione americana risulta strategico: consente di attingere a una tradizione di poetry of witness che in Italia ha avuto sviluppi meno sistematici. Tuttavia, la questione che la raccolta lascia aperta riguarda la possibilità stessa di una poesia civile nell’epoca della spettacolarizzazione del dolore. Come può la poesia sottrarsi al rischio di diventare essa stessa un ulteriore momento di estetizzazione della sofferenza? Come evitare che la rappresentazione delle esistenze marginali si trasformi in un gesto consolatorio che assolve il lettore anziché metterlo in questione?
Mazzanti non offre risposte conclusive a questi interrogativi, ma ha il merito di porli con forza. La nebbia del titolo non è solo metafora dell’oblio o della perdita di memoria, ma anche della zona di indistinzione in cui si muove la poesia quando affronta il reale. Una zona dove vedere e non vedere, dire e tacere, rappresentare e tradire si sovrappongono continuamente. In questo senso, Nebbia costituisce un esordio significativo, che pur con i limiti di una prima raccolta – una certa tendenza alla ripetizione tematica, un’oscillazione stilistica non sempre controllata – indica una direzione di ricerca che merita attenzione. Resta da vedere se nei lavori futuri Mazzanti saprà approfondire questa linea o se cercherà nuove strade, ma il tentativo di costruire una poesia che sia insieme testimonianza e riflessione sulla propria possibilità rappresenta un contributo importante al dibattito sulla funzione della poesia nel presente.