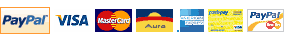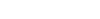Giovanni Laera, su incroci online, per «La solitudine maestosa» di Nefeli Misuraca

La solitudine maestosa
|
|
| autori: | Nefeli Misuraca |
| formato: | Libro |
| prezzo: | |
| vai alla scheda » | |
Nefeli Misuraca, LA SOLITUDINE MAESTOSA. POESIE
prefazione di Guido Oldani, introduzione di Rita Pacilio, La Vita Felice, Milano 2018
di Giovanni Laera
La solitudine maestosa è l’opera prima di Nefeli Misuraca, dottoressa di ricerca in letteratura e docente in diverse università tra l’Europa e l’America. Si tratta di un esordio ponderato, consapevole, capace di offrire molteplici spunti di riflessione a chiunque voglia esplorarne in profondità il testo poetico. Non possiamo che concordare, dunque, con Guido Oldani che nella prefazione al volume parla di una raccolta «non accidentale, ma costruita su poesie che hanno un senso comune di appartenenza».
I componimenti della Misuraca hanno il singolare dono di oscillare, di saper cioè individuare nel percorso esistenziale della poetessa i gradi estremi dell’esperienza, veri e propri confini entro i quali si forgia il linguaggio. La sensibilità di questa autrice riesce a tenere insieme con sapienza nel proprio immaginario gli opposti che lacerano l’individuo contemporaneo. Così la verità della natura, vissuta sottopelle, si scontra – eclissandosi – con la finzione della vita umana: «Questa è la vita che ci appartiene, / una cisterna nuova su un’impalcatura incrostata». Per superare la condizione naturale, però, è necessario attraversarla, riconoscendo i sottili equilibri che la regolano: «Essere civilizzati a forza, questa è la vita che ci appartiene, / attraversare il cumulo di ossa e sussurri / tenendo in equilibrio un libro in testa». «A forza», una locuzione che troviamo anche in altre poesie, perché sia la natura sia la civilizzazione sono vissute e viste sotto i riflettori della necessità («Imbevuta a forza, / si protende la pianta anche se non vuole»).
In particolare, il bestiario che troviamo nei versi di questo libro porge all’autrice un armamentario di metafore e similitudini che ci offre un’ulteriore chiave di lettura per squadernare il contrasto: «E ci vuole il sangue di una salamandra, / la lingua fredda di un camaleonte / e il vestito bianco di una mantide / per prendere borsetta e rossetto, / controllare il gas e le chiavi / e uscire per strada». Ecco come Nefeli mostra il progressivo scivolamento dell’immaginario animalesco verso un ambito semantico umano (e femminile): esemplificativo, a tal proposito, l’accenno all’abbigliamento della mantide, seguito dal richiamo alla borsetta e soprattutto al rossetto, a un maquillage necessario per condurre la propria vita. In quest’ottica vanno lette anche le geishe cantate in Forti come alberi, donne che nascondono «l’ecchimosi, la bolla, i quaranta gradi e passa» con «la pomata per le scottature», il «callifugo», assorte nella quotidianità dei «buoni sconto del supermercato».
L’oscillazione, cifra di queste poesie, innesca una poetica dello sguardo affatto interessante, che svela le dinamiche umane e sociali della nostra realtà. A registrare con precisione tali dinamiche è la poetessa, la cui natura ambivalente, tra l’animale e l’essere umano civilizzato, ne decreta la «solitudine maestosa», la decisione di abitare i suoi giorni «come un animale la sua tana». Non a caso l’autrice si rappresenta come «pavone di mie meraviglie»: il suo lavoro consiste appunto nel «pavoneggiarsi su strascichi immensi / senza paura d’inciampare».
Se i richiami al mondo animale e alla realtà quotidiana della città costituiscono l’immaginario, la ragnatela ordita dalla poetessa per rappresentare sé stessa e gli altri, al di fuori di questa ragnatela è in agguato quello che potremmo definire lacanianamente il Reale, la Cosa informe che invade la realtà, rovinandone l’immagine. In questo orizzonte è il sangue, già versato e rappreso, animale o umano, a indicare la via d’uscita e allo stesso tempo d’ingresso alla poesia. Le tracce del sangue, al di fuori della metropoli, sono indelebili: «La natura non sa dimenticare / il sangue del cervo caduto in corsa contro la pietra / che resta, con il lichene, per sempre sulla roccia». Solo il ritorno a una prospettiva simbolica e oggettuale può annacquare la potenza di quel sacrificio: «Ma nella città, basta un tubo d’acqua / o l’impietoso scorrere dei copertoni / e il sangue rappreso nelle crepe d’asfalto, / scompare insieme all’animale straziato». Ancora, «l’ombra del muso di un gatto / buttato per terra con cura gentile, come nel sonno, / con l’occhio annebbiato su quel poco di bianco fra la striscia e la strada / che scolora dai rulli di verniciatura automatica»; «sulla linea di mezzeria è ancora rappreso il sangue del gatto di quartiere». Il sangue ritorna nei versi con un’insistenza tale da negarne addirittura la finitezza; una breve poesia, intitolata eloquentemente Non si lava, toglie ogni dubbio al riguardo: «Non si lava mai completamente a fondo il sangue / le tracce rimangono come il tempo, che si conta, fino a che la pentola non ha concluso / il suo bollire».
È proprio il tempo a rendere la ferita, doloroso ma necessario punto di partenza del percorso poetico, bagaglio memoriale («Le cicatrici sono la memoria del corpo») e insieme contemplazione quasi distaccata della propria storia («Ci guardiamo le ferite da lontano»). I versi di alcune poesie si allungano a emulare la durata di un’attesa estenuante («L’attesa che i farmaci facciano effetto è ansia vuota di bianchi minuti. / Senza battito o scorcio di luce si addensa il tempo incastrato intorno agli oggetti») e, nel componimento Le labbra, a dilatare vertiginosamente il tempo di una mattina che si riduce poi all’avverbio del brevissimo verso finale («È ancora la vigilia»).
Con questa opera prima Nefeli Misuraca ci offre il suo sguardo lucido e spietato su una realtà in cui il poeta, «commesso viaggiatore dell’abisso», riconosce la nostra natura di «scimmie ammaestrate» da una posizione che non è mai privilegiata: solo all’aria aperta si dà «la vita, non mai, pare, / nei nostri loculi, da cui esce sola, a volte, una poesia». E se l’immagine fugace di un bambino in bicicletta può evocare una «gioia d’esistere infinita», non sfugge all’autrice che «alla fine non resta niente», «forse nemmeno un respiro, non c’è voce / che tenga alla perdita del tutto». Natura paradossale della poesia: testimonianza acuta e al contempo inadeguata dell’esistenza che, pur rilevando la nostra caducità di «atei per forza», apre un varco per l’infinito, un verso in cui «sopravviviamo tutti, per sempre».