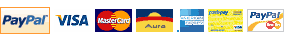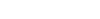Ino Buscaglia a proposito di "Non è che un addio" di Mario Ferrando
13.02.2026

Non è che un addio
|
|
| autori: | Mario Ferrando |
| formato: | Libro |
| prezzo: | |
| vai alla scheda » | |
Questo è un libro che parte dalla morte. E già questo, oggi, è rivoluzionario.
Nella nostra società la morte va nascosta, truccata, negata. La esorcizziamo con la mania della salute, del fitness, dell’eterna giovinezza: anziani “giovanili” fino al grottesco, cura ossessiva del corpo, come se bastasse questo per cancellare l’evidenza che prima o poi tutti moriamo.
Il libro di Mario fa l’operazione opposta: entra nei cimiteri, guarda in faccia la morte e, paradossalmente, ne ricava un inno alla vita. Alla vita intesa come amore per l’umanità, attenzione alle persone, ai loro valori, alle loro contraddizioni. È un libro che parte dalle lapidi e arriva al senso profondo dell’esistenza.
Per scrivere un libro così non basta aggirarsi curiosi tra le tombe del Ponente ligure – ma potrebbero essere i cimiteri di qualsiasi parte del mondo. Ci vuole uno sguardo pieno di umanità, e questo è lo sguardo di Mario.
Mario è un medico. Anch’io sono un medico. Noi medici, volenti o nolenti, con la morte ci parliamo spesso.
Per un pediatra come lui, la morte è qualcosa di osceno, quasi innaturale: riguarda i bambini, che in un mondo giusto non dovrebbero mai morire. Per uno psichiatra come me, la morte sembra un po’ più distante, perché non abbiamo davanti un corpo fisico che si spegne. Ma se provi a scacciarla dalla porta, rientra dalla finestra sotto forma di suicidio, che è l’evento più drammatico e doloroso con cui uno psichiatra può confrontarsi.
Questa familiarità, sofferta ma lucida, con la morte si sente. Mario non si indurisce: mantiene uno sguardo affettuoso e vigile, insieme rigoroso e tenero.
L’idea del libro è semplice e geniale: camminare per i cimiteri del Ponente ligure, leggere le frasi incise sulle lapidi – quelle poche parole che i vivi hanno scelto per condensare una vita – e da lì iniziare un lavoro da detective, da storico, da antropologo. Mario studia, ricostruisce, colloca nel contesto… e poi fa il salto: dal vero al verosimile, dalla cronaca al racconto.
È inevitabile, leggendo queste pagine, pensare alla “Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Masters, che io ho amato molto, e che ha ispirato uno dei dischi più belli di Fabrizio De André, “Non al denaro, non all’amore né al cielo”. Lì sono i morti che parlano in prima persona, in poesia; qui abbiamo racconti, ma la spinta è simile: restituire voce a chi non ce l’ha più.
Adesso dirò una piccola bestemmia letteraria: il libro di Mario, per me oggi, parla più forte di Spoon River.
Non perché sia “migliore” in assoluto, ma perché lo leggo con gli occhi di un quasi settantenne che ha cominciato a fare i conti con la propria morte e che ha capito che cosa conta davvero. Lo sguardo di Mario è per me una consolazione attiva: non consola addormentandoti, ma ricordandoti che ogni vita – anche quella più marginale – ha una sua dignità, un suo peso, un suo splendore.
C’è poi un aspetto che mi ha colpito in modo particolare. Lo sguardo di Mario è affettuoso, rispettoso, benevolente, ma non nel senso buonista del termine: è uno sguardo che esalta l’individualità.
In ogni racconto si sente che l’autore non vuole usare queste vite per dimostrare una tesi, per confermare un’ideologia, per incasellare le persone dentro categorie politiche, sociali o sociologiche. Al contrario, le tira fuori da quelle categorie.
Ognuno dei personaggi del libro è un mondo a sé: ha il suo percorso, le sue contraddizioni, le sue miserie e la sua grandezza. Non è un “esempio” di qualcosa, non è un caso clinico, non è un tipo sociale: è una persona.
In tempi in cui siamo sommersi da discorsi che generalizzano – “gli italiani”, “i migranti”, “i giovani”, “i vecchi”, “i poveri”, “i ricchi”, “i credenti”, “i laici”… – questo libro fa l’operazione opposta: toglie le etichette e restituisce il volto singolare. È un gesto profondamente etico: vuol dire dire all’altro “tu non sei riducibile a una definizione”.
Questa è un’operazione che sento molto vicina a quella che ho provato a fare anch’io con “CIM. Cento imperfetti mondi”: anche lì l’idea era di mostrare come ogni paziente, ogni storia di sofferenza psichica, sia un mondo irriducibile, non un esempio di diagnosi da manuale, non un capitolo di DSM su due gambe. Nel libro di Mario sento la stessa cosa: dietro ogni nome inciso su una lapide c’è un mondo imperfetto, ma unico, che lui prova a raggiungere con discrezione, rispetto e fantasia. Ed è questo, forse, ciò che rende il libro così profondamente umano.
Vorrei raccontarvi una piccola immagine personale, per spiegare che cosa ho sentito leggendo queste pagine.
Quando ero studente, arrivando a Genova in treno, il convoglio rallentava passando accanto ai palazzi che costeggiano la ferrovia. Io guardavo dentro gli appartamenti, attraverso le finestre aperte o le luci accese, e provavo un’emozione fortissima.
Vedevo le credenze con le fotografie di famiglia, i panni stesi, un quotidiano aperto sul tavolo, il giocattolo di un bambino in un angolo… e sentivo una specie di struggimento. Pensavo: “Chissà chi abita lì, chissà che vita fa, qual è la sua storia…” E avevo la sensazione che in quegli interni, in quei frammenti di quotidiano, ci fosse il senso vero dell’esistenza. Una commozione profonda per delle vite che non avrei mai incontrato, ma che intuivo essere piene di gioie, dolori, rabbie, amori, fallimenti.
Ecco, leggendo “Non è che un addio. Vite in un sussurro” ho riconosciuto quella stessa emozione: Mario fa, nei cimiteri del Ponente, quello che io facevo col treno a Genova. Si affaccia sulle vite degli altri con rispetto e curiosità, senza rubare niente, ma cercando di capire, di onorare quelle esistenze.
Le lapidi sono le nostre finestre: poche parole, pochi oggetti appesi al muro. Lui si ferma, ascolta il sussurro e prova a trasformarlo in una storia. E nel farlo, restituisce a quelle persone non solo un ricordo, ma una forma di giustizia narrativa.
Per questo dico che questo è un libro che parte dalla morte ma arriva al trionfo della vita. Ci ricorda che nessuno è solo un nome e due date, e che persino una lapide, se guardata con lo sguardo giusto, può diventare una porta spalancata sull’umanità.
E di questo viaggio, Mario, ti ringrazio davvero.
---
Ino Buscaglia
---
In Spoon River si sente sempre, sotto, una specie di atto d’accusa: Edgar Lee Masters è arrabbiato con il potere, con l’ipocrisia del paese, con le convenzioni sociali. Le voci dei morti spesso servono anche a smascherare la cattiveria, la meschinità, la violenza nascosta dietro le facciate perbene. È un libro potentissimo proprio perché denuncia: “Guardate quanto può essere crudele una comunità”.
Nel libro di Mario Ferrando io sento un’altra atmosfera.
Non che manchino le ingiustizie, le durezza della storia, i torti subiti: ci sono, eccome. Ma lo sguardo dell’autore è meno accusatorio e molto più benevolo. Non mi pare che voglia dimostrare una tesi – per esempio “il potere è cattivo” – né che voglia mettere qualcuno alla gogna.
Mi sembra che il suo movimento sia un altro:
non è “smascherare i cattivi”, ma dare profondità alle persone, anche quando hanno sbagliato, anche quando sono state ambigue, contraddittorie, persino colpevoli. È come se dicesse:
“Non sei solo ciò che hai fatto di storto. Sei un intreccio di scelte, circostanze, fragilità, tentativi di essere all’altezza della vita.”
In questo senso, il libro di Mario mi sembra meno ideologico e più radicalmente umano: non divide il mondo in buoni e cattivi, vincenti e perdenti, oppressori e oppressi, ma prova a restituire la complessità di ciascuno.
Ed è proprio per questo – lo dico con sincerità – che oggi, alla mia età, mi sento più vicino al suo sguardo che alla furia di Spoon River.
Ino Buscaglia